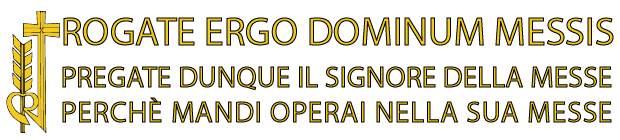XXV domenica del Tempo ordinario
Per gli empi il giusto è sempre scomodo perché con la vita e le sue azioni rimprovera le colpe e rinfaccia le trasgressioni. La verità delle sue parole è messa in dubbio. Dio, invocato a suo sostegno, lo libera dagli avversari e lo salva dalla morte infame. Questa sorte è toccata a Gesù: la predicazione della sua passione è ricorrente, esplicita, e si conclude con la risurrezione. Si fa fatica a comprendere tutto questo: anche gli Apostoli nonostante i ripetuti insegnamenti hanno preferito discutere su chi tra loro fosse più grande. La logica di Cristo è la quella del contrario: chi vuol essere primo deve essere l’ultimo e il servitore di tutti. L’esempio più convincente è il bambino, piccolo, indifeso, attraverso: chi lo accoglie, accogliere Gesù stesso ed il Padre. Gelosia e contese portano disordine, guerre, liti, azioni cattive e rendono infruttuosa la preghiera. La sapienza invece invocata dall’Alto, porta misericordia e buoni frutti. P. Angelo Sardone