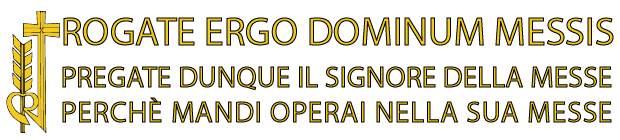Pietro e Cornelio: lo Spirito ai Pagani
298. «Anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita!» (At 11,18). L’apostolo Pietro è appena rientrato da Cesarea dove dimorava il Procuratore romano. Qui aveva incontrato Cornelio, uomo retto e timorato da Dio che, a seguito di una visione, lo aveva mandato a chiamare da Joppe ed insieme con la famiglia era pronto ad ascoltarlo. L’apostolo fa la sua catechesi sul mistero della risurrezione di Cristo e sul perdono dei peccati a seguito della professione delle fede. Lo Spirito Santo scende così sui pagani, con grande meraviglia dei circoncisi. Il Signore non fa distinzione di persone. Ma per Pietro, a Gerusalemme, vi è un sonoro rimprovero da parte degli stessi fedeli, per essere entrato in casa di incirconcisi ed avere mangiato con loro. Non poteva essere assolutamente possibile una cosa del genere. Lo Spirito stravolge questa concezione e rende coraggioso il suo testimone nel raccontare l’accaduto, la visione della tovaglia scesa dal cielo con quadrupedi, rettili e fiere e l’invito fatto per tre volte, a mangiarne. La sua apologia ha il supporto della verità dei fatti e soprattutto dall’intervento dello Spirito che, mentre stava ancora parlando ai pagani, scese su di loro come era sceso sui credenti. «Tutto ciò che Dio ha purificato non è più impuro; Chi ero io per potermi opporre a Dio che così stava intervenendo?» Questi concetti, ribaditi con forza, riescono ad acquetare i suoi accusatori e a far loro affermare che effettivamente Dio ha concesso anche ai pagani di convertirsi per avere la vita. La conversione e la salvezza sono per tutti e non vi si può opporre, nonostante lo zelo ardente degli eletti o di coloro che si credono tali! È Dio stesso che apre la porta ai pagani senza passare per il Giudaismo e la nostra fede bigotta o standardizzata! P. Angelo Sardone