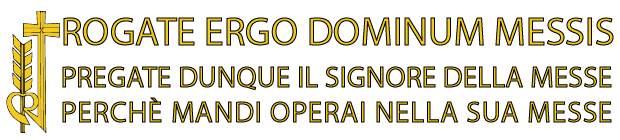San Gregorio Magno
«Gregorio, cercava sempre il volto di Dio e abitava nella gioia del suo amore» (Liturgia propria). La Chiesa ricorda oggi uno dei suoi più grandi papi e santi dottori, Gregorio (540-604) cui fu attribuito il titolo di Magno cioè grande. Romano di nascita e patrizio di provenienza familiare con genitori cristiani, percorse un cammino di impegno molteplice nella società e nella Chiesa: fu avviato alla carriera da senatore e fu Prefetto di Roma, fu monaco e abate del monastero di Sant’Andrea sul Celio e quindi papa. Il suo impegno pastorale fu intenso, molteplice e lungimirante sia nella carità che nell’azione missionaria. La storia lo ricorda come scrittore prolifico in campo spirituale, pastorale e morale, legislatore liturgico e del canto sacro, autore di un Sacramentario che divenne la base del Messale Romano. La vasta esperienza acquisita nel mondo monastico, nella conoscenza dell’Oriente e nella carriera sociale, gli valse per assolvere in maniera egregia il compito di papa su tutti i versanti dell’azione pastorale, dalla liturgia alla carità, dalla legislazione giuridica alla predicazione, dallo studio biblico all’insegnamento. È fondamentale la sua “Regola Pastorale” un’opera di assoluto prestigio sull’identità del vescovo, maestro e pastore del gregge, predicatore, esemplare e punto di riferimento per tutti. La sua azione più efficace rimane comunque il percorso di santificazione in perfetta simbiosi con tutte le attività ecclesiali e sociali. S. Gregorio è un esempio mirabile per i vescovi ed i sacerdoti di ogni tempo e un modello superlativo di sapienza ed intelligenza. P. Angelo Sardone