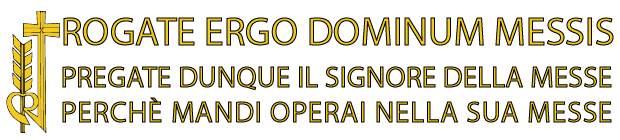Categoria: Senza categoria
Novena a S. Antonio di Padova /1 giorno
E’ cominciata oggi la Novena a S. Antonio di Padova, il santo taumaturgo protettore delle nostre opere che si dicono “antoniane”. redo noto uno schema singolare di Novena scritta da S. Annibale a partire dai termini che compongono il celebre Inno Antoniano “Si quaeris miracula”. P. Angelo Sardone.
Guardare avanti
Mattutino di speranza
4 giugno 2020
Sempre si lascia qualcosa dietro le spalle. È una legge di natura conseguente al fatto di camminare, di procedere, di andare avanti. Dietro si lascia il tempo, le persone, le cose, gli avvenimenti, le emozioni, i sentimenti, il peccato. Si lasciano tante cose buone, una scia di luce che si aggiunge a quelle perenni del cielo. Tutto diventa storia; tutto si traduce in memoria affidata oltre che al passato, al giudizio misericordioso di Dio, alla coscienza personale e collettiva. Ciò che è buono rimane impresso nel ricordo e nella benedizione e va oltre il tempo; ciò che buono non è viene affidato alla benevolenza di Dio, alla sua comprensione del nostro limite umano e al perdono del tempo e della storia. Si guarda avanti. Agli occhi di Dio, «mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte» (Sal 89,4). La Scrittura attesta che «il saggio ha gli occhi in fronte, mentre lo stolto cammina nelle tenebre» (Qo 2,14). La legge del tempo è inesorabile: allontana il presente dal passato e l’avvicina ogni giorno di più all’eternità. Ogni cosa finisce, di ogni cosa c’è il limite e noi ce ne accorgiamo. Tutto passa: solo Dio resta. Verso questa meta siamo proiettati e camminiamo. Il bene fatto, anche quando non lo ricordi, viene inciso e rimane alla conoscenza di Dio e degli uomini. La saggezza popolare ha coniato il significativo motto: «Fa il bene e scordalo! Se fai il male, pensaci!». Nel libro di Dio tutto è scritto, tutto è a Lui noto. La sua identità di giusto giudice della storia, del mondo, dell’uomo, lo pone in relazione giuridica con le creature in termini di verità, ma anche e soprattutto di amore misericordioso che offre al peccatore, anche il più perverso ed astuto, l’opportunità sino alla fine, di pentirsi, di tornare sui suoi passi, di affidarsi a Lui, di guadagnarsi la vita eterna. Il ladrone confitto in croce accanto a Gesù sul Calvario, è l’esempio tipico di come, anche a conclusione di una vita variamente dissipata, sull’orlo di una morte infame, subita a causa delle colpe commesse, si può trovare l’impulso e la forza della fede che fa ascoltare con più attenzione ciò che per troppo tempo si è ascoltato con svogliatezza e superficialità, che fa guardare accanto con gli occhi appannati dal dolore acerbo della solitudine, dell’abbandono da parte di tutti e scorgere finalmente un briciolo di umanità, di coerenza e compassione che forse si è rincorso per tutta una vita e che ora si riesce a strappare con una maggiore lucidità e ferma volontà. Anche il male lasciato indietro, se corredato da una limpida presa di coscienza, da un dolore perfetto, da un pentimento sincero, maturo e duraturo, può essere trasformato in bene. Il letame raccolto nella stalla, con i suoi nauseanti odori, rifiuti organici destinati alla decomposizione, “feccia dispensata dal ventre” come direbbe il poeta Ariosto, si trasforma in concime utile per la terra e la produzione di frutti. Anche il peccato, nauseante condizione di apparente e fatua felicità e consapevole distacco da «tutto ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode» (Fil 4,9), se affidato alla misericordia di Dio con una contrizione sincera, frutto di una lettura attenta della propria vita e di un distacco deciso e fermo dal male, con un proposito serio e perseverante, viene trasformato dalla bontà di Dio in perdono. Lui che ogni giorno fa nuove tutte le cose, provvede ancora di più a rendere nuova la creatura destinando a lui «un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più» (Ap 21,1). Il grande suo perdono è proporzionato al grande nostro pentimento e cambiamento concreto della vita; «dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia» (Rm 5,20). Dio non lo si prende in giro. La responsabilità umana rimane tale e diventa anche principio di condanna se il male è fatto e viene continuato a fare ad occhi aperti, pur conoscendo il valore del bene, se si baratta una perla di grande valore con un miserabile anche se luccicante pezzo di bigiotteria, l’eredità di amore e di bene del Padre per un gustoso piatto di lenticchie. Il Signore ci ripaga secondo l’innocenza delle nostre mani se abbiamo custodito le sue vie, se siamo stati integri con Lui e ci siamo guardati dalla colpa (Sal 17,22). Dopo questi giorni di densa oscurità ci lasciamo dietro le spalle la paura, il disorientamento, il peccato, per proiettarci verso una luminosità nuova che viene resa tale anche dalla diversa considerazione di fatti, persone, dello stesso rapporto con Dio. Gli occhi della testa vedranno diversamente se gli occhi del cuore saranno stati abbagliati dalla luce della verità che, soprattutto in tempo di fitte tenebre, anche se con un minuscolo raggio, mette in evidenza le realtà più nascoste e profonde dell’anima e trasforma il buio pesto in una meravigliosa e splendida luce. La luce di grazia, la luce di Dio. Questo non è un sogno o un pio desiderio: è la nostra fiducia; può essere, se lo vuoi, una vera, appagante realtà. P. Angelo Sardone
Duc in altum!
Mattutino di speranza
3 giugno 2020
Siamo chiamati a prendere il largo. Non si tratta di una libertà concessa, ma di un esplicito invito a rimettersi in barca e gettare le reti. È una vera opportunità per ripartire e ricominciare. La vita dell’uomo, infatti, è un ri-avvio continuo in sincronia con i ritmi delle stagioni e degli avvenimenti che segnano la sua esperienza giornaliera sia ordinaria e ripetitiva, che straordinaria e sconvolgente. Tante volte è duro riavviare e riavviarsi. Si può aver acquisito l’anomalo senso di una stabilità nell’instabilità, di una armonia nella stonata e sgradevole dissonanza, di una sicurezza nella insicurezza, di un ordine apparente nel disordine più evidente, fino a far diventare il tutto, l’unica attuale certezza perché del domani non se ne sa niente. L’invito del Signore rivolto a Pietro «duc in altum, prendi il largo» raccontano da S. Luca nel suo Vangelo (Lc 5, 1-11), è perentorio e precede l’amaro sfogo del pescatore incallito, per una notte trascorsa nel lago senza aver pescato nulla. E’ l’invito rivolto al giovane ed alla giovane, all’uomo ed alla donna di oggi, sconsolati e tristi per una stagione o una vita che ha riservato solo amarezze e delusioni senza fine, tagliati fuori dalla speranza, illusi nella ricerca di qualcosa di grande rivelatosi certezza incerta, ammiccante ed attrattivo specchio di forte illusione su fragili sentimenti, meschini e talora diabolici tranelli colorati con parole melliflue che solleticano il cuore ed il corpo e destano sensazioni che appagano solo per poco ed in superficie. La pesca mancata, tante volte è il risultato di una vita costruita arrancandosi per via, adattandosi alle situazioni anche le più incresciose e funeste, alla ricerca non sempre consapevole di emozioni stagionali che riempiono solo un vuoto interiore, il più delle volte di affetto, che sembrano dare una pienezza e l’incentivo a ricostruire sulle macerie della vita. Senza sapere che in fondo l’ingarbugliano in una rete di confusione talmente grande che, se anche dovesse presentarsi un piccolo pesce, quel meschino riesce a scappare perché le maglie della rete sono larghe e non trattengono nulla, i sentimenti sono confusi e le illusioni sono accecanti. Gesù, anche a seguito di una terribile esperienza come quella attuale della pandemia, vuole servirsi di noi, della nostra miseria, della coscienza di essere peccatori, vuole servirsi della nostra barca (il nostro corpo, la nostra vita, l’intelligenza, la bellezza, la vocazione, la spiritualità anche se fragile ed incerta) dove ha preso un posto straordinario per insegnare a noi e agli altri che sono rimasti a riva dei nostri interessi. Il maestro induce a prendere il largo, senza paura, fidandoci, perchè rimane Lui stesso sulla barca con noi per darci la garanzia più autentica della stabilità sull’onda sferzata dal vento e della sicura raccolta di una pesca abbondante. Ma Cristo è esigente: propone e richiede un serio programma di vita spirituale non camuffato da facili emozioni passeggere e sul filo della simpatia, ma determinato da una volontà decisa a «finirla una volta per sempre con i nostri peccati». Chiede di prendere decisioni precise anche se dolorose per andare verso il largo molto più spazioso ed avvincente di un porto limitato alla presenza di troppe barche e troppi pescatori che ripetono ogni giorno il loro annoiato cliché di un tentativo rassegnato di raccolta dove non abboccano più neppure i pesci più piccoli. Decisioni non affrettate e non sollecitate dall’emozione del momento, ma ponderate sulla base di illuminati consigli di pescatori più saggi che sanno quando è il momento di pescare e quando no, conoscono la veemenza e la pericolosità del mare, sanno adoperare le lampare con la scorta del carburante e sanno rettamente amministrarlo dosandolo per una notte che può durare anche tutta una vita. Se c’è Gesù accanto o se è Lui a nascondersi dentro un “pescatore di uomini”, stabile e non avventizio, generoso ed esigente, perspicace e lungimirante, serio e proteso al vero bene dell’anima, non solo la pesca sarà abbondante, ma ci sarà bisogno di chiamare altri a godere della stessa gioiosa abbondanza. Da quarant’anni io esco ogni giorno per la pesca, affrontando il lago e il mare talora tempestoso ed incerto, con la consapevolezza dell’apprendista in rodaggio e lo stupore incantato del bambino, con la meraviglia sempre nuova di chi tocca con mano l’abbondante Provvidenza di Dio in pesci piccoli e grandi, variopinti e monocromatici, graziosi e gustosi, sani e feriti, che hanno abboccato all’amo o sono volutamente entrati nella rete per essere finalmente valorizzati. Questi pesci io raccolgo con cura scrupolosa ed amore sviscerato, sapendo che non mi appartengono, che sono il bel regalo che sorprendentemente Dio mi riserva e mio grande onore sarà quello di mostrarli orgogliosamente sul banco della vendita ad intenditori accorti e non semplicemente voraci di novità. E questo lo faccio perché sono convinto, come mi spesso mi ripeteva un mio confratello cui devo l’introduzione ed i primi passi nel fascinoso mondo della filosofia, che, come affermava Emmanuel Levinàs, un filosofo francese di origini ebraico-lituane, «dal momento in cui un altro mi guarda, io ne sono responsabile». A maggior ragione quando uno entra nella mia vita, mi si affida, cammina con me, sostiene anche me. P. Angelo Sardone
Siamo davvero cambiati?
Mattutino di speranza
Lunedì 2 giugno 2020
La gioia piena e la guida alla verità tutta intera sono il dono ed il fine ultimo della presenza e dell’opera dello Spirito Santo nella vita del cristiano e della Chiesa. Nella sua predicazione conclusiva, ricca di connotati di forte intensità emotiva e di profonda intimità, condivisi a cuore aperto con gli apostoli, Gesù aveva rivelato queste verità come elementi costitutivi e propri dell’essenza e della missione della terza Persona della santissima Trinità, forza trainante e distintiva della sua evangelizzazione, dono alla Chiesa e sua guida perenne. È proprio lo Spirito, per chi a Lui si consegna con fede matura ed abbandono fiducioso, a guidare la storia personale, ad indicare con delicatezza e sollecitare con fermezza il cammino da seguire nella piena libertà, anche quando non si riesce a comprendere fino in fondo il volere di Dio che supera ogni nostra conoscenza. Lo Spirito Santo, che è l’anima della nostra vita, guida ciascuno nel compimento della sua personale vocazione e missione, alla piena verità ed alla vera pienezza della felicità. A volte però la sua azione viene ostacolata da una resistenza aperta o nascosta, temporanea o talora costume di vita in compiacenza con un’apparente vita spirituale di alta qualità, fatta di devozioni, pratiche di pietà, pii esercizi, digiuni, pellegrinaggi. La resistenza allo Spirito è la resistenza alla grazia «il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà» (CCC, 1996), è la negazione dell’evidenza e della verità, è la certezza autocompiacente anche di una situazione di evidente peccato. Può sfociare in una netta e ferma opposizione, quando, effettivamente, la vita non cambia e le scelte decisionali più importanti che occorre prendere, non sono prese adeguatamente né tanto meno adempiute secondo retta coscienza. E questo diventa un dramma. Quando si oppone resistenza alla grazia, che è Gesù Cristo, si entra nel vortice dell’inganno diabolico e non sempre ci si rende conto. La resistenza nascosta è pericolosissima ed è bisognosa di purificazione e di un taglio radicale col male. L’intero arco temporale della pandemia, al di là delle ristrettezze sopportate, delle tante morti, della paura del contagio, della privazione della libertà e delle risorse sacramentali più necessarie ed a portata di mano con l’esperienza della vita comunitaria, ha imposto nuove abitudini determinate dalla necessità della continuità del lavoro, del ritmo della scuola e dell’insegnamento, delle relazioni sociali. Seppure è stato un dramma, può essere una vera opportunità per cambiare vita. Tanti sono diventati maestri, virologi, avvocati, psicologi, esperti tuttologi, affrettati consolatori, venditori gratuiti e non di pareri e soluzioni ineccepibili, dietro la video camera di un cellulare, occhio fotografante e trasmettitore di emozioni, sorrisi, lagrime, mettendo la propria privacy sulla bocca e negli occhi di tutti. La confusione a volte è diventata grande, gli allarmismi asfissianti, le ventate apocalittiche paurose, le soluzioni a portata di mano, le affermazioni confuse, alternanti e contrastanti in malcelate verità o menzogne. Si è cercato di esorcizzare la paura, cantando dai balconi, poi ci si è resi conto che il gesto apotropaico non ha funzionato molto per bloccare il contagio, almeno fino quando un uomo vestito di bianco, claudicante, col capo scoperto sotto la pioggia scrosciante, con le mani vuote di certezze umane e piene di fede, portando sulle sue deboli spalle i bisogni dell’intera umanità sconfitta dal male, ha sfidato i giudizi del mondo intero andando verso Gesù Crocifisso, il grande sconfitto, sostandovi nel silenzio angosciante di morte. Poi in quello pulsante di vita davanti all’augusto sacramento eucaristico col quale ha benedetto il mondo intero implorando la misericordia e la fine del dramma. In tutto questo tempo e con tanti avvenimenti, il Signore e lo Spirito hanno parlato. Abbiamo ascoltato? Abbiamo percepito e compreso quanto ci è stato detto? Le chiese chiuse sono state riaperte per l’accoglienza dei fedeli, i sacramenti per essere amministrati nel rispetto di tutte le norme. Non c’è stata e non credo ci sarà movida spirituale e religiosa, almeno lungo i navigli d’acqua battesimale ed i banchi delle chiese e le mense eucaristiche. Vige ancora tanta paura. Ed è comprensibile. Spero tanto però che, come ha recentemente detto il papa siamo davvero cambiati, ridimensionati nelle nostre facili e superficiali onnipotenze, siamo tutti un po’ diversi con una coscienza più matura, consapevoli che «Dio scampa dai pericoli al di là di ogni speranza umana», come dice S. Basilio Magno e che, tutti i peccati saranno perdonati, eccetto quelli contro lo Spirito, cioè la resistenza consapevole e piena alla grazia. Occorre realizzare non solo a parole ma con i fatti e la verità, un affidamento più concreto e serio all’azione dello Spirito, mettendo da parte inevitabili resistenze, soffuse perplessità, facili pregiudizi, netti rifiuti, accogliendo invece la grazia che come un torrente in piena scorre verso di noi. P. Angelo Sardone
Solennità di S. Annibale
Mattutino di speranza
1° giugno 2020
La prima e fondamentale vocazione del cristiano è la propria santificazione. Anzi questa è la stessa volontà di Dio (1Tes 4,3), inscritta nella natura umana che pone l’uomo in relazione intima, profonda e continua col Creatore e Signore della vita. Si realizza in un cammino giornaliero, nell’esercizio delle virtù teologiche ed umane entro i parametri segnati dalla Grazia dei sacramenti e dalla preghiera. Pur nella consapevolezza della miseria e del proprio limite umano dovuto al peccato, il santo è colui che si distacca realmente da tutto ciò che non porta a Dio e tutto a Lui orienta. Santo è colui che ha la testa fissa in Dio, non per aria, ed il corpo del viandante, che calca la terra e le sue realtà con lo sguardo rivolto al cielo, ivi proiettando e finalizzando la sua esistenza con la ricchezza dei suoi valori: sentimenti, affetti, operazioni, certezze, dolori, speranze. È colui che sublima ogni realtà umana, persone, cose, interessi, portandola ad un livello superiore di fede e di abbandono in Dio che ogni cosa volge al bene. Si lascia fecondare nell’intimo dalla forza misteriosa dello Spirito che gli immette l’energia vitale, lo solleva dalla caduta e dal peccato, lo orienta al vero, al bene. La sua vita è dominata da Dio, la sua volontà è fissa in Dio, la sua felicità è Dio stesso, il primo amore dal quale scaturisce e nel quale si inquadra ogni altro amore. Il santo non è chi fa cose straordinarie, ma chi compie straordinariamente bene le cose ordinarie. Non è facile comprendere queste realtà fino a quando non ci si lascia soggiogare dalla grazia, non si apre finalmente il cuore a Dio ed a Lui si chiede: «Fammi santo come tu sei santo!». Oggi si celebra il “dies natalis”, cioè il giorno natalizio alla vita che non ha fine, e la santità conclamata anche in terra di Annibale Maria Di Francia, un campione di virtù ed un esempio di vita veramente evangelica, un santo dei tempi moderni, Di lui un vescovo disse: «Vuol essere a forza santo!» E così è stato non col parossismo superbo e vuoto delle parole, ma con la concretezza dell’unione perfetta con Dio per puro amore, in un felicissimo stato di grazia, che non ha bisogno di operare grandi prodigi, perché già questo è il massimo dei prodigi. Annibale Di Francia non è solamente il Fondatore delle due Congregazioni delle Figlie del Divino Zelo e dei Rogazionisti del Cuore di Gesù, è mio padre, padre nella fede, padre della mia vita spirituale, padre e modello nella passione del carisma del Rogate, ossia della preghiera ed azione per le vocazioni, una vera malattia che ha contaminato e condizionato per sempre il mio cuore e per la quale non c’è medicina. La sua vita terrena si iscrive in due elementi essenziali, complementari ed unificanti: l’amore per Dio e per il prossimo. La formazione ricevuta in famiglia, l’intuizione del Rogate, frutto di una speciale illuminazione dello Spirito, l’amore ai poveri vissuto per cinquant’anni nel Quartiere Avignone di Messina e dei vari luoghi in cui la Provvidenza lo chiamò ad operare, sono gli elementi portanti di una santità che si è imposta nella Chiesa e che ha generato una famiglia di religiosi e laici che seguendo la sua scia di vita continuano oggi la sua missione. Nell’ordinarietà ha vissuto la dedizione d’amore verso i piccoli ed i poveri, testimoniando fino all’eroismo che la più autentica carità verso Dio è mettersi a suo servizio nel compimento della personale vocazione, e la carità più fruttuosa verso il prossimo è la cura, l’attenzione, la solidarietà, la preoccupazione viva e concreta della salvezza delle anime, nessuna esclusa. Sono stato toccato dal suo amore e dalla sua particolare paternità e rimango ogni giorno incantato dalla ricchezza dei suoi scritti, dall’attualità delle sue intuizioni, dal suo amore sviscerato per Gesù e Maria, per la Chiesa ed il papa, per la gran messe delle anime che necessita di buoni operai. Ho avuto la grande sorte di essere stato chiamato a realizzare la mia vita umana e sacerdotale nella vocazione rogazionista: essa mi configura prima di tutto come suo figlio, mi accorda al suo cuore e fa sentire anche il mio cuore «trafitto da tanta rovina specialmente per le tenere messi che sono le nascenti generazioni», per le quali il rimedio più efficace è proprio la preghiera e l’azione per le vocazioni. Al Rogate anche io dedico i miei giorni, i miei pensieri, i miei affetti, il mio lavoro, le mie sofferenze per le anime. Esso è il fuoco insopprimibile nel mio cuore, un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa senza alcuna possibilità di contenerlo. Per il Rogate anche io sono pronto a dare il sangue e la mia stessa vita. P. Angelo Sardone.
Sentinella a tutte le ore
Mattutino di speranza
31 maggio 2020
La Sacra Scrittura spesso riporta episodi di straordinaria valenza umana, alcuni anche molto toccanti, che contengono insegnamenti imperituri e situazioni emotive e spirituali nei quali si rispecchia la nostra vita. Uno di questi che mi ha sempre colpito e coinvolto emotivamente fino alle lagrime, si riferisce a situazioni concrete che vivo come sacerdote immerso nel servizio pastorale ai laici. Si trova negli Atti degli Apostoli (At 20,13-38) e riporta le raccomandazioni a cuore aperto di S. Paolo ed il saluto d’addio alla comunità cristiana di Efeso, in Asia minore. Tre anni di lavoro pastorale, giorno e notte, avevano cementato oltre che una solida amicizia in Cristo, uno sviscerato amore dell’Apostolo nei confronti di quei primi cristiani ed i collaboratori in particolare, che lo avevano accolto, ascoltato, amato e considerato come un padre. Altrettanto amore egli aveva dimostrato per loro, senza tirarsi mai indietro anche nelle dure prove, reggendosi con le sue stesse risorse, operando prodigi, predicando, ammonendo con fermezza e dolcezza, annunciando la volontà di Dio e predicando la conversione. Consapevole della sua responsabilità, del grande lavoro fatto e prevenendo una situazione che poteva crearsi dopo la sua partenza, in forza di quanto con tanta fatica e lagrime aveva compiuto, dà le sue ultime raccomandazioni che sono di una straordinaria finezza umana e pastorale. Infatti mettono in guardia piccoli e grandi, dai «lupi rapaci che non risparmieranno il gregge», e da alcuni, anche buoni, che «sorgeranno a parlare di cose perverse, per attirare dietro di sé i discepoli». La vigilanza, la memoria di quanto egli ha fatto e di ciò che hanno ricevuto, il ricorso alla preghiera, saranno il metodo più efficace di prevenzione e di resistenza al male subdolo. Quante volte mi sono ritrovato in considerazioni e situazioni analoghe, in tanti anni di servizio sacerdotale e pastorale in ambienti e luoghi diversi, con persone e relazioni simili. Certo, non ho la tempra carismatica di Paolo Apostolo, non sono stato rapito al terzo cielo, né tanto meno ho la capacità di guardare l’oltre con i poveri miei occhi se pure accorti, ma solo pochi elementi umani di sudata conoscenza acquisita sul campo e nel rapporto giornaliero con Gesù Eucaristia, di intuizione perspicace, di prevenzione e forse un minimo di capacità di leggere oltre le righe e guardare oltre le immagini. Quanta sofferenza provo nel vedere persone raccolte dal fango, ripulite e rivestite di Grazia, avviate a più spirituale fortuna, ma ancora molto fragili per poter camminare da soli, sottrarsi volutamente alla cura amorevole e lasciarsi cadere nelle trappole diaboliche, col prurito delle sensazioni e della novità facile ed attraente degli strilloni di turno, del sensazionalismo estetico fisico e verbale, in una pseudo appagante felicità dal tempo limitato di una stagione. Cosa mi resta? L’affidamento di queste persone al Signore ed alla sua grazia, che ha il potere di edificare e di santificare, la preghiera costante umile e fiduciosa, la continuazione dell’accompagnamento vigile e forse nascosto ai loro occhi, ma noto a Dio, l’offerta giornaliera sull’altare insieme col pane e col vino. I membri della comunità di Efeso accompagnarono Paolo alla nave: piangevano, gli si gettavano al collo e lo baciavano addolorati perchè non avrebbero visto più il suo volto. Quante volte questo copione è stata ed è la mia vita, coinvolto emotivamente e fisicamente, con la volontà e il desiderio unico di fare e di volere il bene di tutti e di chi, ancor più misteriosamente, il Signore ha posto sulla mia strada e collocato dentro il mio cuore. Nella sua bontà il Signore mi ha sorretto, nel suo amore mi ha illuminato e guidato, nella sua fiducia mi ha dato un nome: «Sentinella» (Ez 3,16). Ed io voglio esserlo non solo del mattino, ma anche del giorno e della notte (Is 21,11-12). Chiedo a Gesù sommo ed eterno sacerdote la forza di portare quest’onere di paternità e di viverlo nell’oblazione fino alla morte. Chiedo allo Spirito consolatore la grazia di fare luce e verità in me, perché possa dare luce e verità agli altri e continuare ad essere mio malgrado, “portatore di luce, di perdono e di vita”. Chiedo a Maria il dono del suo silenzio e della custodia di ogni cosa nel cuore. Chiedo anche a te che mi ascolti o che mi leggi una preghiera perché tutto questo possa esserlo fino in fondo. Grazie. P. Angelo Sardone
Pentecoste
Pentecoste. L’Apostolo Giovanni riferisce nel suo Vangelo che la stessa sera della Risurrezione, preceduto dal saluto di pace e dal mandato missionario, Gesù diede agli Apostoli il dono dello Spirito Santo, insieme col potere di rimettere i peccati. Gli Atti degli Apostoli narrano invece che l’effusione dello Spirito avvenne il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, nel contesto dell’antica festa di Pentecoste nella quale si ricordava il dono della Legge data a Mosè. Lo Spirito Santo scende sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo sotto forma di lingue di fuoco e dà loro il potere di proclamare in lingue diverse le grandi opere di Dio ai tanti stranieri che affollano Gerusalemme. È il fenomeno della glossolalìa. Si può dire «Gesù è Signore!» solo sotto l’azione dello Spirito Santo che distribuisce carismi e ministeri nelle diverse attività. A ciascuno viene data una sua particolare manifestazione per il bene comune. Siamo stati battezzati e dissetati da un solo Spirito: per questo camminiamo nello Spirito. P. Angelo Sardone
Il “grande sconosciuto”
Mattutino di speranza, Sabato 30 maggio 2020.
Per tanto tempo lo Spirito Santo è stato il «grande sconosciuto». Questo rilievo fu fatto da San Josemaría Escrivà (1902-1975), fondatore dell’Opus Dei ed anche dal cardinale belga Léon-Joseph Suenens (1904 –1996) uno dei protagonisti del Concilio Vaticano II. Il teologo svizzero, Hans Urs von Balthasar (1905-1988) vi aggiunse: «Lo sconosciuto che viene oltre il Verbo». Nel corso di questi ultimi 50 anni, grazie alla nuova coscienza pneumatologica nata dal Vaticano II e dai Movimenti ecclesiali che ne fanno specifico riferimento, il santo e divino Spirito è più conosciuto. La terza persona della SS.ma Trinità, uno col Padre e col Figlio come proclamiamo nel Simbolo della fede, è comunione ed amore tra le divine persone, forza, potenza, dono. Per dinamismo delle sue azioni si configura in una serie di simboli: l’acqua nel Battesimo, l’unzione dell’olio nell’iniziazione cristiana e nel sacramento dell’Ordine, (Gesù è costituito “Cristo” dallo Spirito Santo), il fuoco che brucia e trasforma, la nube, la luce, l’ombra che copre la Vergine Maria e la rende Madre di Gesù, il sigillo, il marchio che indica l’effetto indelebile della sua unzione, l’imposizione delle mani nella epiclesi per la consacrazione durante la Messa, il dito di Dio, la colomba che scende su Gesù dopo il suo battesimo. Queste nozioni catechetiche sono i primi elementi per comprendere e valorizzare lo Spirito Santo che abita in noi: «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Per tanti cristiani, oggi, purtroppo, vale la stessa espressione di quelli di Efeso al tempo dell’apostolo Paolo: «Non abbiamo nemmeno sentito che esista uno Spirito Santo» (At 19, 2). Lo Spirito che è vita, luce e guida, conferisce sette doni (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio) e produce nove frutti indicati nella lettera ai Galati: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22). Sono spazi di amore e realtà di vita nei quali entrare per lasciarsi dominare dallo Spirito e in Lui camminare. Lo Spirito infatti forgia e custodisce la vita spirituale, mettendola in decisa opposizione ai ben noti desideri della carne (fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; Gal 5,19-21). Possono sembrare realtà di altri tempi, retaggi scolastici del Medioevo, tranelli architettati per tenere sotto scacco e dominio psicologico i fragili, gli illusi, asservendoli ad assurde privazioni o ad anguste concezioni che rendono la vita ed il piacere frustranti, inconcludenti, dannosi. Sono invece le realtà spirituali della vita da riscoprire, valorizzare, e adoperare rettamente per dare un senso adeguato a ciò che si crede ed a come si crede. Non ci si può attendere qualche vigorosa sferzata dello Spirito su una possibile via di Damasco né tantomeno subire lo sconvolgimento globale di una terribile pandemia con contagi, paura e morti in quantità, per aprire gli occhi e rendersi conto che nella vita non c’è solo materia, accumulo e consumo di denaro, frenesia di dominio, perversioni morali, corruzione ad ogni livello, superbia. Ci sono tante altre cose che si vedono, si leggono e si comprendono solo con gli occhi dello Spirito, con la luce della interiorità, con la purezza dell’animo, con la retta intenzione, diretti dalla forza imperativa dell’amore che vede ed orienta al bene. Spero tanto, e me lo auguro davvero con tutto il cuore che la precaria situazione dalla quale sembra che gradualmente stiamo uscendo, almeno abbia fatto aprire gli occhi per rendersi conto che non siamo solo materia da alimentare, corpi da vestire e soddisfare nei bisogni naturali o indotti. C’è bisogno di un cammino e di una alimentazione spirituale che avviene efficacemente con l’uso della Grazia e dei Sacramenti. C’è bisogno di un rivestimento sicuro che è quello dello Spirito, di un lavorìo che forgia l’animo, la mente, il cuore ed è affidato al cesello dello Spirito. C’è bisogno di una lingua di verità che si opponga alla babele ed alla confusione di lingue, comportamenti ed azioni. C’è bisogno di un dono che faccia piena chiarezza e verità dentro di noi, di un amore superlativo che contagia e guarisce. C’è bisogno davvero e con urgenza di aprire la vita allo Spirito Santo nella sua perenne effusione d’amore. P. Angelo Sardone.