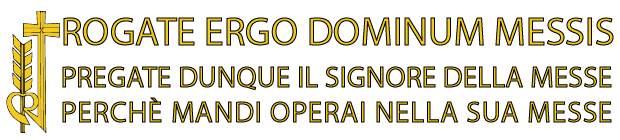Le tavole della Legge
«Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiar pane e senza bere acqua» (Es 34,28). Il dettagliato racconto del Libro dell’Esodo si concentra particolarmente sul dono dei Comandamenti. Avvertito direttamente da Dio che il popolo si era pervertito forgiando un vitello d’oro dinanzi al quale si era prostrato, Mosè si affrettò a scendere dal monte con in mano le tavole della Testimonianza. Su di esse Dio aveva inciso davanti e di dietro la sua Legge. Visto il vitello e le danze ed udito i suoni Mosè spezzò le tavole ai piedi della montagna. Poi fece il resto: ridusse in polvere il vitello, lo versò nell’acqua e la fece trangugiare agli Israeliti. Il Signore lo richiamò sul monte Sinai gli fece portare due tavole di pietra come le prime e, dopo averlo trattenuto per quaranta giorni e quaranta notti senza mangiare e bere, su di esse ancora una volta incise il Decalogo, le dieci parole dell’Alleanza. Si tratta di una forma altamente immaginifica che stabilisce l’origine divina e l’autorità stessa del Decalogo. Come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, esso è il primo stadio della Legge rivelata che pone i fondamenti della vocazione dell’uomo. È la sintesi di ciò che è contrario all’amore di Dio e del prossimo e la prescrizione di ciò che è essenziale. «Dio ha scritto sulle tavole della Legge ciò che gli uomini non riuscivano a leggere nei loro cuori» (Sant’Agostino). Sono i principi validi per tutti gli uomini, lo spiraglio di luce che offre alla coscienza di ogni uomo la via del bene e la libera da ogni orientamento al male. P. Angelo Sardone